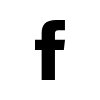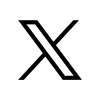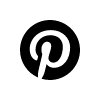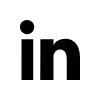Linee curve e avvolgenti, tonalità mute e terrose ispirate alla natura, geometrie che anche quando si fanno un po' più ardite non vanno mai a penalizzare la comodità, fantasiose declinazioni di corde o fibre intrecciate: sono le caratteristiche salienti delle proposte outdoor presentate in fiera dalle aziende del settore. Ve le raccontiamo
“Il bravo architetto? Sa ascoltare gli altri”. Parla Ottavio Di Blasi

ODB & Partners, Campus di Architettura Politecnico di Milano, ph. Enrico Cano studio, courtesy Ottavio Di Blasi
Far diventare le città più umane per lui è la sfida del millennio. Per questo è impegnato in una serie di progetti di “ricucitura urbana”. Come quello recente del Campus di Architettura del Politecnico di Milano
È rimasto un rapporto davvero amichevole, ci si capisce al volo, al punto che a volte è sufficiente una telefonata per fare un progetto assieme. Abbiamo tante passioni in comune e condividiamo l’idea dell’architettura come “scatola di montaggio”. Dopo che sono andato via dal suo studio ci siamo ritrovati e questo mi ha fatto molto piacere. Si lavora bene
È più facile dire quando si ha a che fare con un buon architetto piuttosto che con un buon progetto. Perché un buon architetto ha una caratteristica che lo rende riconoscibile: sa ascoltare gli altri, dove per “gli altri” non intendo soltanto i propri clienti e collaboratori, ma gli altri in senso lato, l’Altro. Un buon progetto allora non è che il risultato di un’azione di sintesi su tanti stimoli che si sono ricevuti rispetto a un problema. Si potrebbe dire quindi che un buon architetto è una sorta di “gestore”, uno che raccoglie informazioni su argomenti diversissimi – simbolici, economici, costruttivi, sociali – e riesce a dare loro un senso assieme. Un po’ come un pasticcere che crea un impasto. Ecco, quando la torta viene bene, quello è buon progetto.

ODB & Partners, Campus di Architettura Politecnico di Milano, ph. Enrico Cano studio, courtesy Ottavio Di Blasi
Tutto è nato da un dono che Renzo Piano ha fatto al Politecnico. Il rettore ha chiesto a lui, che è un ex studente di questa università, come me del resto, cosa bisognasse fare per migliorarlo. Renzo Piano ha fatto degli schizzi che il rettore, dopo avere incorniciato, ha voluto tradurre in un progetto reale. Io sono stato chiamato a realizzarlo; lo abbiamo inaugurato a giugno. Lo si può riassumere così: il Campus di Architettura si era formato nel dopoguerra dopo l’intervento di Giò Ponti per rispondere a esigenze di spazio che ogni anno aumentavano, per cui alla fine era diventato un assortimento di fabbricati eterogenei. Quello che abbiamo fatto è stato demolire tutte le strutture secondarie che impedivano la fruizione degli edifici di Giò Ponti, costruire degli spazi didattici nuovi staccati dagli edifici storici e piantare 130 alberi.
Quando usiamo la parola “campus” ci riferiamo a una tipologia anglosassone in cui l’università usciva dalla città e si inseriva in un contesto agricolo, costituendo una sorta di organismo autonomo. Al contrario, nell’Europa continentale l’università si è sviluppata attaccata alla città ed è cresciuta utilizzandone i servizi, per cui negli edifici si faceva esclusivamente didattica. Il risultato è che la densità edilizia delle università dell’Europa continentale è cinque volte quella delle università americane. Quindi alle università europee manca lo spazio per gli studenti. Che è esattamente quello che abbiamo fatto al Campus di Architettura del Politecnico di Milano: creare più spazio e aggiungere verde, realizzando percorsi pedonali anche per la collettività e insomma facendo diventare Città Studi un pezzo di città – tra l’altro il nome stesso lo dice. In questo sta anche il ruolo urbanistico dei campus urbani, ovvero stringere legami con i pezzi di città che stanno attorno. È un tema che ritorna in molti nostri progetti in ambito Educational, come nel Campus UPO – Università del Piemonte Orientale, nell’Università degli Studi di Padova e altri in sviluppo.

ODB & Partners, Università del Piemonte Orientale, Novara, ph. Beppe Raso, courtesy Ottavio Di Blasi
Credo che Richard Rogers abbia dato un grosso contributo a questo tema del futuro della città. Lavorando per Tony Blair, infatti, ha creato un documento che si chiama Towards an Urban Renaissance, dove ha individuato alcune linee guida strategiche che secondo me rimangono attuali. Prima di tutto la città deve essere più densa, perché altrimenti consuma più territorio. Quindi bisogna costruire sul “brownfield” e non sul “greenfield”, cosa che ormai i piani regolatori più avanzati, come quello di Milano, danno per scontato. Più densa ma meglio connessa, con un livello di trasporto pubblico efficiente. Infine, la città non deve limitarsi a consumare energia, ma deve produrla lei. E qui entra in gioco il fotovoltaico, che è l’unica energia davvero alternativa che oggi abbiamo a disposizione. Noi, per esempio, stiamo realizzando la stazione di Sesto San Giovanni, che è una sorta di prototipo di architettura ferroviaria di nuova generazione, perché ha 3.500 metri quadrati di copertura fotovoltaica.
Le periferie sono le città di domani in uno spazio urbano che cresce. Spesso sono talmente vaste che non c’è l’energia economica per affrontare il problema nel suo complesso. Quindi bisogna prima di tutto conoscerle nelle loro specificità, vale a dire riconoscere le energie vitali presenti sul territorio – i mercati rionali, le associazioni giovanili, gli operatori sociali – e poi individuare interventi piccoli ma estremamente mirati. Una sorta di approccio “omeopatico” in poche parole, dove con poca energia si riescono ad avere grandi risultati. Al Giambellino, per esempio, abbiamo demolito un muro e aperto una porta tra il mercato rionale e il parco. Questo intervento, sia pure piccolissimo, è riuscito a innescare dei meccanismi virtuosi di fruizione del quartiere.
Una delle sfide che abbiamo in corso è quella del Memorial de Gorée, un progetto bandito dall’UNESCO che abbiamo vinto più di vent’anni fa per realizzare il memoriale della tratta degli schiavi a Dakar, nel punto più occidentale di tutta l’Africa. Teniamo molto poi ai progetti legati al rapporto tra città e università, come quello per ridisegnare il Campus Umanistico della Statale di Milano, nel quartiere storico che si affaccia su via Celoria. È molto ambizioso perché non si tratta solo di far funzionare le università ma di riqualificare le città che le ospitano. Questo è un tema che porteremo avanti negli anni a venire.